1 – WHAT IS LEFT?
Il contesto politico in cui si tenne il 1° Convegno dei partiti socialisti-socialdemocratici e dei sindacati a Parigi, richiamano gli anni che avevano visto la repentina caduta del Muro di Berlino; il tentativo fallito di Gorbaciov di riformare dall’interno, in senso democratico, il regime sovietico. (Lo stesso Gorbaciov affermò di voler tornare allo spirito democratico di Lenin (sic!): chissà, forse si illudeva riferendosi a Lenin di addomesticare la forte opposizione che incontrò la sua iniziativa politica nel Partito comunista sovietico). Mentre in Italia il gruppo dirigente del Pci si era scervellato a inventare e propagandare la cosiddetta “terza via” e il “compromesso storico”. Nel primo capitolo del libro non mi dilungo sul punto, concludo riprendendo la dichiarazione a quei tempi rilasciata da Bronislaw Geremek, deputato alla Dieta polacca: “Il sistema comunista non può essere riformato: preso atto del suo patologico sviluppo storico, va definito “via senza uscita”.
Furono anche anni di grande fermento intellettuale e politico, certo dovuto al crollo del regime comunista internazionale. Mi limito solo ad alcune citazioni e valutazioni che ricordano quei momenti. Da più parti veniva posta la domanda: What is left? Cos’è la sinistra?
Ricordo che nel 1992, lo stesso anno di uscita del mio libro, Francis Fukuyama scrisse un saggio pubblicato in italiano come “La fine della storia e l’ultimo uomo”. Alcuni anni prima Ralf Dahrendorf aveva scritto: “Il conflitto sociale nella modernità”, al quale – punto sul vivo come socialista -, mi ero proposto di rispondere col mio saggio. Intanto le fibrillazioni erano al massimo grado tra i partiti socialisti europei. Vivaddio, finalmente non ci sarebbero stati più equivoci: erano i partiti socialisti-socialdemocratici l’unica, vera, autentica sinistra! I leader e la classe dirigente socialista europea erano impegnati su questo fronte: si scrivevano articoli e rilasciavano dichiarazioni; si moltiplicavano i dibattiti e si tenevano incontri. In quei momenti di fermento generale, i socialisti francesi erano i più attivi nel cercare di occupare il centro della scena politica. Vi erano per così dire iniziative di prima linea e altre minori. Francamente non saprei dire se quella che mi coinvolse appartenesse al secondo girone.
2 – I CONVEGNI TRA I PARTITI SOCIALISTI-SOCIALDEMOCRATICI E I SINDACATI EUROPEI
Accadde così che un giorno mi dissero di ricevere la persona che svolgeva nel Partito socialista francese i miei stessi compiti. Il delegato francese mi informò che era già d’accordo con i rappresentanti della socialdemocrazia tedesca e scandinava per concordare – riassumo – delle iniziative a livello europeo che rinsaldassero i rapporti di vicinanza politica tra socialismo e sindacalismo. Ora a tanti anni di distanza non ricordo più i loro nomi; quando poi li conobbi personalmente, erano tipi simpatici e affiatati come i tre moschettieri, e presto ci saremmo integrati. Il rappresentante francese era venuto a Roma per capire se il Psi era interessato a tali iniziative, e (dandolo per scontato) per conoscere il quarto moschettiere da arruolare. Nessuno di loro tre aveva fatto esperienze nel sindacato. Il francese mascherò bene il suo stupore quando gli raccontai la mia storia di sindacalista, che prima di entrare nel partito socialista in pianta stabile, avevo fatto una lunga gavetta nel sindacato: a cominciare dalla Commissione Interna nella fabbrica dove i miei compagni di lavoro mi avevano eletto, e via via ricoprendo incarichi di segreteria quale rappresentante della componente socialista ai diversi livelli in cui era strutturata la Cgil; e terminato la mia lunga esperienza da segretario generale aggiunto della Federbraccianti. E in questa veste divenuto vice presidente dei sindacati agricoli europei a Bruxelles alla fine degli anni ‘70. E dunque conoscevo abbastanza bene in lungo e in largo l’Europa. (Poi accennerò qui e là alle esperienze vissute nel sindacato. Ora mi preme chiarire che la mia prima formazione politica giovanile non fu propriamente socialista, ma orientata sulle posizioni espresse nei convegni tenuti negli anni ‘50 dagli “Amici del Mondo” di Pannunzio: filiazione post bellica del movimento politico e di lotta partigiana “Giustizia e Libertà”; e se ne parlo, è perché ciò ha un nesso con la impostazione del libro che poi ho scritto).
Il francese mi arruolò seduta stante tra i moschettieri. Fu per me una ulteriore e bella esperienza. Il primo incontro collegiale si svolse nella sede del Partito socialista francese, che se ben ricordo era ubicata come adesso a Rue de Solferino a Parigi. Degli altri incontri ne rammento in particolare due: il primo si tenne nella cittadina tedesca mitica per la socialdemocrazia europea: Bad Godesberg, dove nel ’59 i socialdemocratici tedeschi ratificarono il Programma “che spedì Karl Marx in soffitta”.
Grosso modo in quegli stessi anni in Italia i due leader del Psi e del Psdi, Nenni e Saragat, ripresero a incontrarsi (nel primo dopoguerra Saragat aveva sbattuto la porta in faccia a Nenni, dopo che questi si era legato mani e piedi al Pci). La ripresa del dialogo si sarebbe conclusa positivamente dopo una lunga gestazione in casa Psi, con l’Unificazione Socialista avvenuta nel 1966. Purtroppo, si trattò di una esperienza politica che sarebbe durata meno di tre anni. A mio parere, il suo fallimento fu determinato da diversi fattori: dai finanziamenti che i sovietici misero a disposizione per far fallire l’operazione socialista in Italia; dalla forte opposizione della minoranza di sinistra del Psi (questa, beninteso, legittima), per una operazione politica chiaramente socialdemocratica, alla base dell’Unificazione Socialista; da una sorta di vocazione dei socialisti più a distinguersi soggettivamente che a unirsi collettivamente.
3 – BAD GODESBERG
Per quanto mi riguarda fu solo dopo che Nenni abbandonò la linea ‘frontista’ col Pci e aprì la stagione politica ‘autonomista’, che mi iscrissi al Partito socialista. Di quegli anni ricordo l’entusiasmo di noi giovani socialisti che con la mia Fiat 500 andavamo in giro ad affiggere i manifesti ed ad annunciare con l’altoparlante che gracchiava i comizi decisi dalla nostra sezione di partito. Dunque si capisce come Bad Godesberg rappresentasse per me il centro fisico del mio mondo politico: il ‘socialismo liberale’.
Ostellino in un articolo sul Corriere della Sera trattando del tema del liberalismo, citava il filosofo Benedetto Croce “che definiva liberalismo un pre-partito che avrebbe dovuto informare tutti gli altri in una società aperta”. Purtroppo In Italia una tale, limpida definizione non ha mai avuto molti estimatori. Ma per quanto mi riguarda, condivido pienamente tale definizione; al punto da qualificare sempre con l’aggettivo liberale il sostantivo socialismo.
Così molti anni dopo il fallimento dell’Unificazione Socialista, e durante una pausa di lavoro in preparazione della 1° Conferenza di Parigi nella sede Spd di Bad Godesberg, colsi l’occasione per andarmene da solo a fare quattro passi nella cittadina; mi sedetti in un bar e ordinai dello strudel. Sarà stata l’aria, non so, ma il gusto delizioso di quel dolce non l’ho mai più provato come lo provai allora in quel luogo.
Il secondo incontro avvenne in una tenuta a qualche ora di auto da Stoccolma di proprietà del Partito socialdemocratico svedese, costituita da una villa forse fine Ottocento con intorno strutture moderne per l’accoglienza degli ospiti, sale riunioni, ecc. Ricordo una persona del posto: ci tenne a informarmi che quella proprietà era stata acquistata con i contributi degli operai svedesi. E lo disse con quel tono serioso e orgoglioso, che anni addietro avresti potuto vedere stampato sul volto del segretario comunista di una cittadina emiliana, mentre t’informava che la Casa del Popolo locale era stata costruita col contributo degli iscritti al partito…
4 – IL CONVEGNO DI PARIGI
Il 1° Convegno dei partiti socialisti-socialdemocratici e dei sindacati europei si svolse nella grande sala della Citè des Sciences et de l’Industrie in località La Villette a Parigi, dove – mi disse l’amico francese – anni prima sorgeva il vecchio mattatoio parigino. Uno dei massimi dirigenti comunisti della Cgil, Bruno Trentin, intervenne al convegno e poi ritornammo insieme a Roma. Mi chiese qual era il programma futuro: gli risposi che non era stato ancora deciso, e che lo avrei tenuto informato.
(Va detto che nei convegni di cui parlo non era tanto importante il tema generale, che veniva indicato al dibattito; all’indomani del crollo del comunismo internazionale. Importante era il fatto politico in sé: che sindacalisti e socialisti-socialdemocratici europei si incontrassero per discutere insieme dei problemi socio-economici nei singoli paesi e in Europa).
Dopo Parigi, i tre moschettieri mi dissero di privilegiare Roma come sede del 2°Convegno; ottimo risposi. E l’amico francese precisò che contavano sulla presenza e l’intervento del segretario del Psi, Bettino Craxi al convegno. Una richiesta scontata: infatti a Parigi era intervenuto alla manifestazione il segretario del Partito socialista francese, e noi principali organizzatori eravamo stati ricevuti dal Primo Ministro, Michel Rocard.
La richiesta di tenere il 2° Convegno a Roma aveva un chiaro significato politico: Bettino Craxi si era ormai imposto quale riferimento di primo piano del socialismo europeo; e i tre moschettieri ci tenevano a vedere e ascoltare il socialista che da Presidente del Consiglio del governo italiano era riuscito a ridurre drasticamente l’inflazione in Italia, riportandola dalle due cifre su cui viaggiava spedita verso il disastro economico-finanziario, a una sola cifra; che aveva tenuto testa agli americani nella cosiddetta Crisi di Sigonella, mantenendo fermo il principio che sul proprio territorio l’Italia non accettava interferenze anche da parte del grande Paese amico che ci aveva liberati dal nazi-fascismo; e dunque ci tenevano a conoscere il primo leader socialista italiano di prestigio internazionale, anche per gli incarichi speciali assegnati a Craxi in sede Onu.
Così mi misi subito al lavoro per il pieno successo del 2° Convegno dei partiti socialisti-socialdemocratici e dei sindacati europei. Allora non potevo sapere che si era messo in moto il pool di Mani Pulite di Milano; che di lì a non molto il Psi avrebbe cessato di esistere, e di conseguenza sarebbe stato annullato il Convegno che stavo organizzando a Roma…
Ora prima di chiarire cosa avvenne quando esplose il patatrac, mi pare importante per comprendere meglio i fatti politici di cui si parla, approfondire l’evoluzione dei rapporti tra socialisti e comunisti; naturalmente dal punto di vista della mia esperienza, sindacale e politica.
5 – SOCIALISTI & COMUNISTI
Il segretario del Psi Bettino Craxi e il leader della Cgil Luciano Lama erano due grandi oratori. Non scadevano mai nel populismo e nella demagogia; i loro discorsi seguivano sempre il filo logico che con abilità avevano già disteso verso l’obiettivo che si erano proposti di raggiungere. Ma avevano modi differenti per sottolineare i passaggi più importanti su cui richiamare la massima attenzione dell’uditorio: Craxi allungava la mano e con l’indice indicava un punto indefinito verso l’alto; Lama prendeva i fogli con le due mani e mentre affermava, ad esempio, l’esigenza di tener conto “degli interessi/generali/del Paese”, scandiva le parole alzando e abbassando i fogli con decisione ritmica, come un direttore d’orchestra che in un passaggio dello spartito richiami tutti alla massima partecipazione e attenzione.
I comunisti li conoscevo bene come le mie tasche: quando loro sentivano il richiamo della foresta, abbassavano la testa e correvano dritti verso quel richiamo. Era già successo al tempo dell’invasione sovietica in Ungheria nel ’56. Allora il leader della Cgil, Di Vittorio, prese posizione a favore degli operai ungheresi e contro l’intervento dei carri armati sovietici. Il richiamo della foresta di Togliatti lo costrinse obtorto collo a seguire gli ordini del Pci (come poi spiegherò, Di Vittorio rappresenta per molti aspetti un’eccezione alla regola del comportamento ortodosso dei comunisti). Lama in un Consiglio generale della Cgil (forse per dimostrare che lui era diverso, non saprei) disse en passant che da giovane aveva aderito al Pci perché era il partito della sinistra meglio organizzato. Il recente libro di Gianpaolo Pansa, “Bella Ciao”, Rizzoli, alla pagina 209 mi ha ricordato i particolari: “Nell’Uli, poi diventato Partito italiano del lavoro, militava anche un giovane di 22 anni. Luciano Lama, romagnolo di Gambettola. In seguito passò ai comunisti e molto tempo dopo divenne segretario generale della Cgil”.
Di sicuro Lama voleva l’unità sindacale; tuttavia da buon comunista, quando Berlinguer lanciò il richiamo della foresta contro l’iniziativa del governo Craxi (il socialista Craxi!) che si proponeva di bloccare il processo inflazionistico divenuto ormai incontrollabile e ricondurlo entro i binari europei, Lama non esitò un attimo a seguire quel richiamo e a rompere di fatto l’unità d’azione con la Cisl e la Uil. I due sindacati non ebbero difficoltà a dichiarare a gran voce una verità lapalissiana: l’alta inflazione colpiva innanzitutto i lavoratori e i pensionati a reddito fisso, perciò era nel loro stesso interesse che il governo si proponesse di invertire la tendenza al continuo aumento del costo della vita, anche congelando solo parzialmente l’indennità di contingenza: importante che il conto finale risultasse positivo per i lavoratori. Ma a Berlinguer non importava che questo discorso filasse liscio come l’olio; importante era riaffermare con forza che la sinistra in Italia s’identificava col Pci, al quale il Psi e i sindacati dovevano rimanere subordinati. A Berlinguer non passò neppure per l’anticamera del cervello un possibile piano B: aprire un confronto serio con i socialisti per avviare insieme la costruzione di un forte partito socialdemocratico (o comunque socialista d’impronta europea) nel nostro Paese. E tutto lascia prevedere che se si fosse compiuta una tale, grande operazione politica – sostenuta da scelte coerenti di politica economica, sociale e industriale-, l’Italia oggi non si troverebbe nelle disastrate condizioni in cui si dibatte.
Ma il Pci era figlio della Rivoluzione d’Ottobre in Russia, e ciò ha sempre condizionato il modo d’essere e di operare dei comunisti. Tant’è che quando crollò il regime sovietico (un vero trauma per la stragrande maggioranza dei comunisti, al tempo stesso politico e psicologico), il segretario Occhetto avrebbe potuto iniziare il discorso ai quadri del partito, ricordando che Terracini, uno dei padri fondatori del Pci, poco prima di morire riconobbe che a Livorno – nella scissione del ’21 del partito socialista dalla quale nacque il Pci -, aveva ragione Turati. Tuttavia Occhetto si guardò bene dal dirlo: evidentemente anche nella sua mente un piano B non esisteva. Ma chi era Filippo Turati invocato da Terracini prima di morire? Lascio che a rispondere sia Montanelli, cui un lettore immagino assiduo come me della sua “Stanza” sul Corriere della Sera, aveva rivolto la stessa domanda.
[Turati era poco ‘italiano’, titolava “La stanza” di Montanelli; che spiegava ai lettori le ragioni del feroce attacco che subì Turati dagli ‘opposti estremismi’ (leggi: Mussolini e Togliatti). Il confronto Mussolini-Turati, “era quello tra il socialismo rivoluzionario, massimalista e piazzaiolo (espresso dal Mussolini ancora socialista), e quello progressista e riformista che nelle altre lingue si chiamava socialdemocrazia (espresso da Turati)”. Dunque il socialista Mussolini attaccò Turati come un borghese ‘incipriato’ di falso socialismo al servizio del nemico di classe con cui faceva sotto banco combutta contro le classi popolari in giusta rivolta contro quelle privilegiate; in seguito il Mussolini diventato capo del Fascismo, non mancò ancora di attaccare duramente Turati (paladino della democrazia) perché era contro le ‘forze sane’ che volevano ricostruire Ordine, Stato e Nazione.
“Ma era pressappoco per le stesse ragioni – prosegue Montanelli – che Turati era il bersaglio dell’odio di Togliatti, che lo definiva un Giuda venduto e ladro; e che non poteva certo perdonargli di essere stato tra i più fieri oppositori dell’adesione del socialismo italiano alla Internazionale comunista sovietica… due socialismi che mai avrebbero potuto trovare un punto di conciliazione… e se dopo la Liberazione, al posto di Nenni si fosse trovato Turati… oggi ci troveremmo con un centrosinistra a netta prevalenza socialdemocratica, perfettamente omologato a quello dei nostri soci europei”
“Per Turati, Mussolini e Togliatti furono soltanto degli ‘avversari’ – puntualizza Montanelli – contro i quali egli non usò mai altre armi che quelle della ragione… e che perse la sua battaglia presso una pubblica opinione che, alla scelta tra ragione e la violenza, fra la teatralità e la moderazione, non esita a seguire il peggio. Ecco uno dei motivi, anche se non l’unico, –conclude – per cui è stato dimenticato: Turati era poco ‘italiano’ “].
6 – I SOCIALISTI DELLA CGIL
Non c’è bisogno di spendere molte parole per far comprendere che i socialisti della Cgil – lavorando fianco a fianco con i comunisti (e questo accadeva anche nelle amministrazioni comunali di sinistra, nelle cooperative e in altre svariate organizzazioni sociali) -, erano per forza di cose favorevoli al piano B; cioè all’unità su base socialdemocratica tra comunisti e socialisti.
Tuttavia il sindacato non è un partito politico; dunque la componente socialista aveva avanzato delle proposte di cambiamento coerenti col piano B, ma che riguardavano specificatamente il sindacato della Cgil (su cui tornerò dopo aver brevemente parlato della mia esperienza nel sindacato).
Le mie idee sul sindacato si formarono nel vivo dell’esperienza diretta nel posto di lavoro, e in seguito partecipando alla vita dell’organizzazione sindacale con ruoli di responsabilità. Appena entrai nel sindacato della Fiom provinciale di Roma, appresi subito i fondamentali del sindacalista impegnato al tavolo delle trattative. Un operaio metalmeccanico romano mi disse: “Mario, non dimenticarlo mai: pancia piena non pensa a quella vuota”; cui seguirono le indicazioni di un maturo sindacalista comunista: “Mario, se nella trattativa intravedi la possibilità di un accordo, allora incolla il sedere sulla sedia e non muoverlo dovessi stare lì per ore e ore; ma se dall’altra parte del tavolo vogliono fare i duri, tu devi essere più duro di loro”. Beh, tutto sommato credo di aver fatto un buon lavoro nei lunghi anni della mia vita vissuti nel sindacato; certo anche il sindacato mi ha dato molto.
Iniziai il mio cursus honorum nel sindacato metalmeccanici nel periodo in cui eravamo impegnati ad affermare nelle aziende la contrattazione dei premi di produzione. Non incontrai difficoltà a svolgere l’attività di sostegno alle Commissioni Interne, anche per aiutarle a definire le richieste che esse avrebbero presentato alle rispettive controparti aziendali. Infatti sapevo bene cosa bisognasse fare: prima di entrare nel sindacato provinciale, ero stato segretario della Commissione Interna della Società italiana telecomunicazioni. Dopo quell’esperienza di categoria andai a organizzare dal nulla la Camera del lavoro di Pomezia, in quella specie di Far West che si era creato a sud di Roma sul limite della zona di operatività della Cassa del Mezzogiorno, dove le aziende nascevano e morivano di continuo, ma sempre dopo aver incamerato i contributi dello Stato; allora toccai con mano quant’è vero il detto: per imparare a nuotare bisogna gettarsi in acqua.
Quindi entrai nella segreteria della Camera del lavoro di Roma, e il mio primo incarico fu di responsabile dell’ufficio vertenze. Non nego che mi ha fatto molto piacere alcuni anni fa, ricevere ancora degli apprezzamenti da un avvocato del sindacato ora in pensione come me, per il ruolo che allora svolsi nello stimolare gli uffici legali, ciascuno operante entro i confini della propria categoria, a raccordarsi per indicare delle proposte di riforma che la Camera del Lavoro poi avrebbe sostenuto in sede politica; tra le altre, ricordo l’impegno degli uffici legali per la riforma del processo del lavoro (mai avrei immaginato che i rapporti organizzativi con gli uffici legali e la comprensione in generale delle tematiche in materia legale, dopo molti anni mi sarebbero tornati utili quando il Psi chiuse i battenti e dovetti cercarmi un nuovo lavoro).
Invece, alla segreteria della Federbraccianti ci arrivai dopo essermi cimentato con le politiche dell’agricoltura da responsabile regionale del Lazio della Cgil. Uno dei vantaggi dell’agricoltura, se vuoi conoscere il mondo, sta nel fatto che le organizzazioni che se ne interessano sono presenti dappertutto: nelle province italiane, in Europa e nel mondo; dunque anche nei paesi arabi. Con i sindacati arabi bisognava seguire una “sceneggiata” al momento di redigere il comunicato finale dell’incontro: loro volevano fosse riportata la condanna d’Israele; sul punto noi insistevamo che fossero richiamati i pronunciamenti dell’Onu, e solo dopo una lunga discussione passava la nostra proposta. Ma con il dovuto rispetto, solo Allah sa cosa essi avrebbero scritto in arabo sui loro giornali.
I lavoratori agricoli sono gente tosta e generosa. Oggi molti di quei lavori sono svolti da lavoratori extracomunitari. L’agricoltura in quanto settore produttivo ha la necessità di integrarsi con l’industria alimentare o con le attività di commercializzazione dei prodotti agricoli per aumentare il proprio peso contrattuale nella filiera che porta i prodotti agricoli trasformati o lavorati sulla tavola dei consumatori; e ciò per ottenere un corrispettivo economico più vantaggioso per le attività di lavoro agricole. Il problema riguarda innanzitutto i produttori autonomi del settore. Ma la mia idea era che anche i lavoratori dipendenti avrebbero potuto indicare la strada giusta da seguire; così, l’ultima cosa che feci prima di lasciare il sindacato, fu proporre di unificare la Federbraccianti col sindacato degli alimentaristi… Ma la sto tirando troppo per le lunghe con i miei ricordi di sindacalista.
7 – IL LEADER BRUNO BUOZZI
“Il Compromesso dinamico” lo scrissi dopo una vita trascorsa nel sindacato e in seguito nel Partito socialista. Recita la dedica del mio libro: “A Bruno Buozzi, Maestro del sindacalismo riformista italiano”. E in altra pagina, che precede la Introduzione, campeggia una frase del socialdemocratico tedesco, Eduard Bernstein (parole che comparvero in un suo articolo pubblicato nel 1896 da Neue Zeit, e che all’epoca suscitò perplessità perfino tra gli stessi socialisti riformisti): “Il movimento è tutto; lo scopo finale del socialismo, nulla”. Forse il titolo del libro “Il compromesso dinamico”, inconsciamente mi è stato suggerito proprio da questa frase riportata da George D.H. Cole nella sua storia del movimento socialista; che riprendeva la lettera di chiarimento inviata da Bernstein al partito socialdemocratico tedesco, nella quale affermava che “Egli non era affatto indifferente alla realizzazione finale dei princìpi socialisti, ma piuttosto alla forma che avrebbe assunto la sistemazione definitiva”.
Per quelli ai quali il nome del sindacalista socialista Bruno Buozzi dice poco o niente, ricordo in estrema sintesi che egli fu tra i più autorevoli sindacalisti italiani della prima metà del Novecento e deputato socialista dal 1920 al 1926. Perseguitato dal regime fascista, nell’ottobre del 1926 si trasferì in Francia dove ricostituì la sede del sindacato italiano all’estero, si occupò della difesa dei diritti dei lavoratori emigrati e fece attiva opera antifascista attraverso il giornale “L’Operaio Italiano” che venne anche fatto circolare clandestinamente in Italia; catturato in Francia dai tedeschi nel 1942 e consegnato all’Italia, fu confinato a Montefalco. Liberato dopo il 25 luglio 1943, lavorò da posizione preminente per la rinascita del sindacato unico in Italia; tuttavia Buozzi non poté firmare il Patto di Roma con il comunista Di Vittorio e il cattolico Achille Grandi (Patto che avrebbe segnato la rinascita della Cgil; che purtroppo negli anni seguenti si sarebbe divisa in conseguenza delle vicende politiche che contrassegnarono la storia del Paese dei primi anni della Repubblica). Buozzi fu arrestato durante l’occupazione nazista di Roma, e questo fu il motivo che gli impedì di firmare l’accordo per la rinascita del sindacato in Italia. La mattina del 4 giugno 1944 (poco prima che gli Alleati entrassero in città) Buozzi venne ucciso lungo la via Cassia dai nazisti in fuga.
La figlia di Buozzi, Jole, avrebbe poi sposato il futuro ambasciatore di Francia in Italia, Gilles Martinet. Feci recapitare il mio libro “Il compromesso dinamico”, appena pubblicato, alla signora Jole tramite l’ambasciata francese. A stretto giro di posta ricevetti un gentile biglietto di ringraziamento di Martinet e della moglie. Purtroppo solo di recente, cliccando sui siti web, mi è capitato di leggere l’intervista rilasciata dalla figlia di Buozzi a Daniela Pasti su “la Repubblica” nel maggio 1984; in cui Jole ricorda episodi toccanti degli anni dell’esilio francese e degli incontri in casa Buozzi con i massimi dirigenti socialisti italiani; due dei quali sarebbero poi diventati Presidenti della Repubblica, Saragat e Pertini. Peccato che mi sia sfuggita quella intervista, di certo l’avrei citata nel mio libro.
Nei colloqui informali a latere delle prime riunioni della componente socialista della Cgil, sentii manifestare alcuni dubbi dai più anziani sindacalisti riguardo gli avvenimenti che portarono alla morte di Buozzi. Si poneva una domanda: come mai nei giorni di prigionia a Roma di Buozzi, mentre esponenti socialisti della Resistenza erano riusciti a far uscire di prigione alcune personalità politiche (evidentemente corrompendo le persone giuste), invece fallirono nei ripetuti tentativi che essi fecero per liberare Buozzi?
Di sicuro con Buozzi libero, la storia del sindacato e del partito socialista italiano nel dopoguerra sarebbero state radicalmente diverse: intanto era dato per scontato che Buozzi sarebbe diventato il segretario generale della Cgil; e che il disastro procurato da Nenni nel legarsi mani e piedi al Pci, di sicuro sarebbe stato impedito. Con Buozzi vivo, il riformismo socialista si sarebbe affermato fin dai primi vagiti della Repubblica. Insomma, la storia d’Italia del dopoguerra sarebbe risultata completamente diversa da quella che conosciamo; tanto per cominciare, non fondata sul duopolio Dc/Pci.
La seconda guerra mondiale era in atto quando uccisero Buozzi, ma già le forze che sarebbero state protagoniste della “guerra fredda” muovevano le loro pedine per configurare il futuro politico del mondo. Tuttavia senza prove o riscontri oggettivi che nessuno ha mai fornito, ciò non bastava a muovere l’accusa che ci sarebbe stata una ‘soffiata’ da parte di qualcuno per indicare ai nazifascisti l’appartamento in cui Buozzi si nascondeva; e che poi lo stesso qualcuno sarebbe riuscito a impedire che andassero a buon fine le iniziative socialiste per liberarlo. Certo tutto ciò può rientrare nel campo delle supposizioni o delle congetture. È curioso come noi socialisti ci facciamo degli scrupoli prima di muovere con certezza delle accuse, mentre sempre a sinistra c’è chi ha solo certezze da affermare. Per esempio: durante il boom economico, il capitalismo italiano subì certo un grave colpo nei primi anni ’60 con le morti di Adriano Olivetti, dell’ingegnere italo-cinese Mario Tchou (genio dell’informatica dell’Olivetti) e poi di Enrico Mattei. Dietro queste morti è stata ventilata l’accusa che c’era la lunga mano delle grandi corporation americane. Tuttavia, come nel caso di Buozzi, si rimane nel campo delle supposizioni o delle congetture, ma non delle certezze.
(P.S. Le morti eccellenti del gruppo Olivetti non chiariscono la posizione marginale dello stesso Gruppo rispetto ai colossi mondiali del settore, e proprio nel periodo di enorme espansione che permane e si svilupperà ulteriormente dei prodotti “informatici”. Infatti una tale marginalizzazione non c’è stata all’Eni dopo la morte di Enrico Mattei. La domanda è: come mai nessun giornale italiano ha indagato e spiegato ai propri lettori i motivi della marginalizzazione del gruppo Olivetti?)
8 – L’IMPEGNO DEI SINDACALISTI SOCIALISTI PER CAMBIARE LA CGIL
Le proposte dei sindacalisti socialisti per la revisione della politica della Cgil (che si svilupparono a partire dagli inizi degli anni ’60) si articolavano su 4 punti; e l’ultimo, l’unità sindacale tra Cgil, Cisl e Uil noi socialisti eravamo convinti che avrebbe indirettamente anche favorito la realizzazione del piano B: l’unità tra i due partiti della sinistra italiana su base socialdemocratica, o comunque sulle posizioni espresse dal socialismo europeo.
Va detto che all’interno della Cgil non si trattò di un braccio di ferro, ma di un confronto nel quale una parte importante e variabile dei comunisti (a seconda del tema e del momento) spingeva nella nostra medesima direzione. I primi tre punti gradualmente passarono: 1) la rottura del rapporto di affiliazione della Cgil alla federazione sindacale mondiale sovietica; 2) lo stabilire l’incompatibilità tra incarichi sindacali e di partito, al fine di rompere con la tradizione leninista del sindacato cinghia di trasmissione del partito comunista (dopo molti anni dai fatti che racconto, e sempre sul tema dei rapporti sindacato-partito, il presidente americano Bill Clinton espresse una opinione che condivido: “Un conto è dire il partito del sindacato, altro è dire il partito che ha rapporti col sindacato”); 3) la democrazia sindacale in casa Cgil: un tema allora ostico per i comunisti non abituati a votare (se non per acclamazione) come noi socialisti nei nostri congressi di partito. Tuttavia arrivammo finalmente al congresso della Cgil in cui votammo a scrutinio segreto con tanto di preferenze il gruppo dirigente dell’organizzazione (ora a tanti anni di distanza e dopo che è stata liquidata la componente socialista, non so come vadano le cose ai congressi della Cgil); 4) riguardo l’unità sindacale in Cgil eravamo tutti d’accordo; ma non lo era tutta la Cisl.
Ricordo un episodio: chiesi un incontro a quattr’occhi con il responsabile Cisl del settore dell’agricoltura che conoscevo bene, il quale era tra i maggiori oppositori del processo di unità sindacale; sorvolai sui successi dei socialisti per modificare le posizioni tradizionali dei comunisti nella Cgil, e andai subito al sodo: gli dissi che se il motivo della sua preoccupazione era di rimanere fagocitato dai comunisti, ciò non sarebbe stato possibile visto che Cisl. Uil e socialisti della Cgil erano in larga maggioranza nel sindacato. Dunque? Mi rispose che infatti lui non temeva questa possibilità a livello nazionale; la temeva in periferia a causa dell’abilità e capacità di condizionamento dei comunisti… Conclusione: l’unità tra le tre maggiori confederazioni sindacali non si fece. Invece l’unità l’avrebbero fatta i metalmeccanici della Cgil, Cisl e Uil; ma siccome il gruppo dirigente che nacque dalla fusione delle tre sigle non volle seguire l’esperienza dei sindacati tedeschi, ne venne fuori una sorta di “terza via” in campo sindacale. Così anche questo esperimento all’italiana fallì.
Per comprendere il senso politico della ripresa del Psi guidato da Craxi, è importante ripensare al periodo antecedente tale ripresa.
9 – COSA FU IL 1968?
Giampaolo Pansa nel tracciare un bilancio di quel periodo, si esprime con efficacia lapidaria: “Straordinaria stagione di grandi slanci, di enormi sciocchezze e di terribili errori”. Il mio libro riprende le domande che si poneva Darhendorf: Cosa significò veramente il ’68? Fu la rivolta dei figli viziati di una nuova prospera classe prodotta dal miracolo economico? Fu la sollevazione dei cittadini contro i governi che non avevano capito che era finito il tempo dei sudditi? Fu la prima affermazione del cambiamento dei valori che di lì a poco avrebbero avvolto le civiltà occidentali? Fu semplicemente una fase della riforma della società moderna con istituzioni che erano sostanzialmente in ritardo con il cambiamento? Tali domande erano poste da Darhendorf nel contesto di un lungo ragionamento che lo porterà a concludere che la socialdemocrazia aveva esaurito il suo compito storico, e che si erano create le condizioni per un nuovo liberalismo.
Darhendorf non mi pare cogliesse appieno la ventata libertaria che investì tutto l’Occidente, causata dalla variopinta e fantasiosa contestazione giovanile, che aveva alcune caratteristiche presenti ovunque: l’antimilitarismo, la critica del familismo, dell’arrivismo e del consumismo, la difesa dei diritti umani, l’aspirazione a una maggiore democrazia e giustizia sociale nella società, la solidarietà con gli oppressi…
Nel libro “Hans Kung, ciò che credo”, Rizzoli, pag. 113, il sacerdote cattolico non allineato come è noto con la Chiesa ufficiale, così descrive quegli anni: “Il lavoro, il successo, il denaro, la carriera, il prestigio sociale, infatti, non erano più al centro dell’interesse della generazione in rivolta, degli studenti e dei loro simpatizzanti nei media e nei partiti politici. Al loro posto c’erano adesso l’utopia, la critica sociale e l’azione, l’ostilità alle convenzioni, l’assenza di vincoli, l’autonomia, l’autorealizzazione. Era questo il nuovo motto e in cui personalmente, malgrado ogni critica e a differenza di Joseph Ratzinger, scoprii molte cose vere e buone” (peccato che la critica finale di Kung a Ratzinger ignori il coraggio mostrato dall’ex Papa nel combattere il fenomeno diffuso della pedofilia nella Chiesa. E un tale giudizio preconcetto di Kung offusca in qualche modo le sue parole – condivisibili – su cosa fu il ‘68).
Come molti di noi, Oriana Fallaci ebbe posizioni contrastanti nei confronti del movimento del’68. In una conferenza del 1976 disse che la rivolta studentesca scoppiata a Parigi quell’anno fu “la prima rivolta intellettuale di massa mai vista nella storia. Tanto eccezionale e importante da aver influenzato la cultura e la politica degli anni successivi”. Eppure durante quel tumultuoso periodo, in Niente e così sia, irride “gli studenti borghesi che osano invocare Che Guevara e poi vivono in case con l’aria condizionata, a scuola ci vanno con la fuoriserie di papà”. Per lei quei studenti erano solo figli di ricchi che giocavano alla rivoluzione. Pensiero condiviso anche dal suo amico Pasolini, che durante gli scontri di Valle Giulia non si schierò con gli studenti “capelloni”, ma con i poliziotti, perché loro sì che erano i figli di operai e avevano conosciuto la miseria. Col poeta friulano Oriana mantenne sempre un rapporto speciale, che la spinse anche a indagare assieme al compagno Panagulis sulla sua misteriosa morte.
Infine sono venuti i riconoscimenti degli errori commessi. Ne colgo uno. Su Il Messaggero di domenica 15 dicembre 2013, nelle pagine di cronaca è comparso un articolo che a leggerlo ti viene una stretta al cuore, e che si conclude con un abbraccio ideale tra una giornalista sessantottina e una giovane laureata. “Voglio lasciare l’Italia”, affermava Viviana; “Ti capisco e mi vergogno”, rispondeva la giornalista Lucetta Scaraffia. Viviana, 30 anni, laureata senza lavoro racconta la sua storia e la sfiducia nel futuro. Dopo il dottorato e le borse di studio non vivo la vita, la sto rincorrendo; ogni sfida ora non ha senso qui. Cerco stabilità e il diritto a essere madre; non ho certezze: so che sarò obbligata a partire. Ora al di là del percorso personale di Viviana, è evidente che il suo rapporto con la nostra Patria matrigna, è lo stesso che vivono purtroppo milioni di giovani italiani. La giornalista Scaraffia risponde alla giovane con coraggio: “noi sessantottini volevamo cambiare il mondo ma poi abbiamo occupato tutti i posti senza pensare ai giovani… e molti di noi, ancora oggi, non vogliono mollare la presa, nonostante l’età… Invece di rifare il mondo, ve ne consegniamo uno molto peggiore di quello che abbiamo ricevuto… la scuola che avete frequentato è stata peggiore di quella che abbiamo fatto noi, la società che vi circonda è più corrotta e depressa, tanto da rendere difficile pensare senza angoscia al futuro…” (A leggere l’intero articolo, viene da rammaricarsi che in Italia non vi sia un premio Pulitzer per il giornalismo).
10 – ALCUNE RIFLESSIONI SUI COMUNISTI
Ora intendo focalizzare l’attenzione su coloro che concorsero negli anni al fallimento del piano B, e indicare il motivo che impedì loro di prendere in considerazione una tale proposta: la fedeltà al mito della Rivoluzione d’Ottobre in Russia di Togliatti, e la valutazione comunque positiva della stessa Rivoluzione manifestata da Berlinguer; e questo al di là delle caratteristiche delle due personalità, e del periodo storico più liberale o libertario in cui operò Berlinguer. Ne consegue che mentre la socialdemocrazia moderna era per Togliatti un tradimento degli ideali socialcomunisti, per Berlinguer si trattava di un’altra realtà politica con la quale si poteva certo dialogare; purché non in Italia, in quanto un tale confronto ravvicinato avrebbe potuto offuscare la ricerca della cosiddetta terza via, che solo Dio sa dove avrebbe condotto il nostro Paese.
Togliatti insabbiò o manipolò alcuni scritti di Gramsci – lo dicono oggi molti storici ex comunisti -, in cui si denunciavano le degenerazioni antidemocratiche e non solo del regime sovietico. Beninteso, Gramsci rimase un comunista che avversava anche aspramente il riformismo socialista. Ora sarebbe legittimo aspettarsi dagli stessi storici ex comunisti, che tornino a interrogarsi sul periodo drammatico che culminò nella Rivoluzione d’Ottobre in Russia: se lo sbocco marxista-leninista fosse l’unica opzione possibile della rivolta antizarista cui parteciparono socialisti, liberali, democratici di diversi orientamenti; e cosa pensano dei metodi brutali adottati allora dal leninismo militante, che fece fuori anzitutto i socialisti e i sindacalisti socialisti che non vollero allinearsi sulle posizioni leniniste; e infine valutino con obiettività se un tale comportamento leninista (seppure in uno scenario totalmente diverso, e con i metodi consentiti in un Paese democratico) non abbia ripreso vigore all’interno del Pci dopo il crollo del comunismo internazionale, manifestandosi soprattutto nei confronti del segretario generale del Psi, Bettino Craxi.
Confesso di non aver ben compreso il significato politico della recente riscoperta di Berlinguer nel film diretto da Veltroni. Il film ricorda gli anni terribili attraversati dal nostro Paese: “Un terribile inverno, fatto di disperazione sociale e violenza politica. Un tempo di sangue e di odio, che culminò con il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro”. E allora parliamo di Berlinguer…
11 – ENRICO BERLINGUER
Nel libro ‘L’intervista con il potere’, Rizzoli, Oriana Fallaci così lo ricorda: “Mi piaceva Berlinguer, perché era un gran signore. Un aristocratico nel senso migliore del termine. Un uomo serio, raziocinante, elegante, e in più premuroso… Inoltre non era vanesio, non era presuntuoso. Virtù rara tra i comunisti”.
Espresso questo giudizio sulla persona – che a occhio e croce mi sento di condividere –, Oriana da ottima professionista non fa sconti a nessuno; incalza Berlinguer sui temi più controversi. “L’Unione Sovietica… – lui risponde – pagine nere, delitti terribili, ma io non dimentico che lì è avvenuta la prima rivoluzione vittoriosa dei poveri, degli sfruttati, che lì sono avvenute anche grandi conquiste sociali. Le avrà pur viste…”. Oriana ribatte che è stata solo una volta in Russia, ché poi le hanno negato il visto d’ingresso; e quella volta “Vidi cose nient’affatto esaltanti, e non solo nel campo della libertà”. Poi sbotta: “Ma se il salario di un operaio non bastava a comprare un paio di stivali!”. E Berlinguer: “Lei deve considerare le condizioni in cui si trovava l’Unione sovietica dopo la Prima guerra mondiale…”. E riguardo la posizione del Pci a favore dell’intervento dei carri armati sovietici in Ungheria, Berlinguer dice: “Considerammo che fosse in atto un tentativo pericoloso per la situazione internazionale, cioè che l’insurrezione rischiasse di portare alla guerra… Si lo so che si trattava di operai, di studenti, di popolo. Lo so. Ma l’insurrezione stava passando nelle mani di forze reazionarie… e comunque l’atteggiamento del Pci fu quello… un atteggiamento che a ventiquattr’anni di distanza può anche essere criticato sebbene dicessimo: Questa è l’ultima volta che accettiamo di veder risolvere le cose militarmente…”
Il ritratto di Berlinguer (e quindi del Pci) che ne viene fuori può essere così tratteggiato: permane il cordone ombelicale con Mosca che si manifesta chiaramente nelle sue valutazioni politiche degli avvenimenti internazionali, soprattutto riguardo l’invasione dell’Ungheria; un cordone ombelicale che dopo i fatti ungheresi diviene più flessibile, ma senza interrompersi (del resto ciò si manifesta anche in alcuni altri partiti comunisti europei); un cordone ombelicale che permane (e che rende impraticabile la svolta socialdemocratica) per il semplicissimo motivo… che non si interrompono i finanziamenti dell’Urss al Pci.
Il giornale “Libero” definisce giustamente una bufala la sbandierata e osannata “questione morale” lanciata dai curatori dell’immagine di Berlinguer per affermare il senso di superiorità morale dei comunisti: 1°, perché il Pci ha continuato a beneficiare dei finanziamenti dell’Urss ben oltre gli anni Settanta; 2° perché le personalità politiche nazionali – e tra queste Craxi – prese di mira allora dai comunisti sul tema “morale”, infine sono morte certamente non ricche, o con tesori nascosti da qualche parte del mondo e di cui hanno potuto beneficiare i propri familiari. 3° perché la vera “questione morale” è esplosa con il debito pubblico (Regioni, Sanità, Province) di cui, al pari di altri partiti, ha beneficiato il Pci. Un debito pubblico astronomico col quale il povero Renzi ora è chiamato a fare i conti.
I termini in cui si poneva la questione erano chiari: Berlinguer assegnava al Pci il ruolo egemone nella sinistra italiana; dunque sia ai sindacati che al Psi non rimaneva che ‘adeguarsi’. Per meglio comprendere i danni politici al Paese che procurò Berlinguer, riprendo qui solo la violenta opposizione del Pci alla legge del governo Craxi, che si proponeva di invertire la tendenza all’incremento incontrollato dell’inflazione con la riforma della contingenza. L’iniziativa berlingueriana contro questa legge fu bocciata dal Parlamento, ma subito dopo ripresa con la richiesta di referendum abrogativo della stessa legge. Chissà, forse Berlinguer era convinto che la maggioranza degli italiani avrebbe votato secondo il motto popolare: meglio un uovo oggi (non toccare –oggi – la contingenza così com’è) che una gallina domani (ridurre – domani – il costo della vita). La maggioranza degli italiani dimostrò allora di saper guardare al di là della punta del proprio naso, e bocciò l’iniziativa referendaria di Berlinguer; il quale rimase leninisticamente indifferente al vulnus che aveva prodotto sia nei rapporti tra i sindacati italiani, che con il Partito socialista.
12 – GIUSEPPE DI VITTORIO
Provo una sorta di allergia cronica verso ogni forma di agiografia; riguardasse anche Giuseppe Di Vittorio, che ho molto stimato dopo essermi documentato e approfondito la sua conoscenza quando entrai in Cgil. Dico solo che le sue idee e i suoi comportamenti da segretario generale della organizzazione, hanno avuto una grande influenza nel mio modo di vedere le cose sul ruolo del sindacato nelle aziende e nella società.
Tuttavia non ho conosciuto Di Vittorio di persona; ai suoi tempi ero stato appena assunto nel mio primo lavoro di apprendista in una fabbrica di grandi trasformatori elettrici che si trovava in una zona di Roma chiamata “l’Alberone” vicino la via Appia Nuova. L’operaio iscritto alla Cgil che affiancavo nel lavoro (e nell’attività di promozione del sindacato) era un compaesano di Di Vittorio, e mi parlava spesso di lui: così ho iniziato a conoscerlo.
Di Vittorio, convinto comunista dopo che in gioventù era stato socialista, non aveva dubbi che le idee che professava si conciliassero con il suo atteggiamento di totale autonomia di giudizio. Così non ci pensò due volte a condannare la feroce repressione sovietica in Ungheria nel ’56. Disse: “il socialismo è libertà, il socialismo è giustizia, bontà, umanità. Senza consenso popolare e senza puntare sulla conquista ideale e politica e non sulla coercizione si rischia di far fallire ogni sforzo collettivo di ricostruzione e di rinnovamento” Ma Di Vittorio non aveva fatto i conti con Togliatti: braccio destro di Stalin in Italia, e alla sua morte divenuto il leader comunista europeo più ascoltato a Mosca. L’attacco di Togliatti a Di Vittorio per la sua posizione sui fatti ungheresi fu brutale, lo investì anche sul piano personale. Dopo un anno Di Vittorio morì; ma non le sue idee…
Di Vittorio non rinunciò mai, mai a riproporre in ogni occasione la assoluta necessità nell’interesse dei lavoratori italiani di realizzare l’unità sindacale. E spiegava (mi verrebbe da dire ai leninisti del suo partito; anche se lui da comunista non lo avrebbe mai detto) che la via dell’unità imponeva di tener conto che del sindacato fanno parte lavoratori di differenti orientamenti politici; per cui chi persegue l’unità sindacale è obbligato a non urtare le sensibilità, i sentimenti e le opinioni politiche della molteplicità dei lavoratori che vuole difendere. Certo, può capitare che i problemi sociali si intreccino con quelli politici quando sono di grande interesse per tutti i lavoratori. In questi casi il sindacato deve sostenere attivamente una propria posizione (a questo proposito è giusto precisare che in Italia la Cisl e la Uil non sono mai stati sindacati insensibili ai problemi politici, così come venivano posti da Di Vittorio; i problemi sono sempre sorti, come nel caso di Berlinguer, quando si è preteso di imporre al sindacato una posizione politica di partito; o una proposta già preconfezionata dal governo eludendo ogni possibilità di confronto con i sindacati; o di voler imporre – fregandosene delle regole del gioco democratico –, la volontà di una minoranza alla maggioranza dei lavoratori nelle aziende).
Nel 1955 si verificò la sconfitta della Cgil nelle elezioni di Commissione interna alla Fiat. Di Vittorio non se la prese con la “prepotenza” del padrone, o con la “sottomissione” degli altri sindacati al suo volere. Senza esitazione ammise pubblicamente che la sconfitta era figlia degli sbagli dell’organizzazione che dirigeva (Di Vittorio non visse abbastanza a lungo da vedere che la sua posizione coraggiosa avrebbe prodotto la modernizzazione della contrattazione sindacale anche in casa Cgil, nel senso già indicato dalla Cisl: un esempio è stata la contrattazione articolata aziendale. Ebbene, devo dire che questa lezione di Di Vittorio non l’ho mai dimenticata: in caso di sconfitta, guardare innanzitutto entro se stessi con obiettività, prima di esaminare il quadro generale in cui quella tale sconfitta si è verificata.
Anno 1949. L’Italia era uscita distrutta dalla guerra; rimanevano gli immensi problemi sociali cui dare risposte. Poi lentamente ci sarebbe stata la Ricostruzione; seguita dopo molti anni dal cosiddetto Miracolo Economico. Tuttavia rimango all’anno 1949 per soffermarmi sul progetto straordinario della Cgil guidata da Di Vittorio: il Piano del lavoro per lo sviluppo economico del Paese. Ora non ha importanza parlare delle presunte o vere manchevolezze di quel progetto. In questo capitolo mi sono proposto di mettere a fuoco la figura politico-sindacale di Di Vittorio. Il punto è che il Piano del lavoro (che si poteva sempre integrare, migliorare o cambiare nella sua impostazione) avrebbe dovuto essere elaborato e sostenuto innanzitutto a livello politico di partito. E l’attentato subito da Togliatti l’anno prima non chiarisce il punto; né lo chiarisce l’aspro dibattito politico sul Piano Marshall. Insomma, era compito della nuova classe dirigente politica italiana di assumersi la responsabilità di indicare proposte concrete per la promozione dello sviluppo economico del Paese: ché solo dallo sviluppo economico (e non dalle ideologie) potevano venire le risposte ai problemi di vita della gente. Di Vittorio volle assumersi una tale responsabilità politica; un modo di agire certamente riformista, a prescindere da ogni valutazione di merito del Piano del Lavoro.
13 – PARLIAMO ANCHE DEI GRAVI ERRORI STORICI E PIÙ RECENTI DEI SOCIALISTI
Alcuni storici sostengono con valide ragioni, che la dittatura fascista si sarebbe potuta evitare se ci fosse stato un accordo politico tra il liberale Giolitti e la componente riformista del Partito socialista. Nel riflettere su tale valutazione, tempo fa mi è tornato in mente il libro di Daniel Horowitz: “Storia del movimento sindacale italiano”, nel quale si accennava al progetto dell’allora Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, sulla cogestione dei lavoratori nelle aziende. Cercai il libro nel caos che si era creato col trasloco di abitazione dopo la morte di mia moglie, e non lo trovai. Chiesi lumi a Sergio Romano, titolare della rubrica Lettere al Corriere, che mi fece la cortesia di una risposta. Il quadro socio-politico che egli descrive e nel quale maturò la proposta di Giolitti, chiarisce bene gli avvenimenti di allora. Dunque mi limito qui a riprendere le sue conclusioni, che illuminano la scena politica: “ L’iniziativa di Giolitti fu… poco sostenuta dai due partiti (socialisti e popolari) che preferivano fare la guerra a Giolitti piuttosto che permettergli di conseguire risultati a cui avrebbero dovuto essere sensibili”.
Questa premessa mi consente di tornare sul tema del riformismo socialista. Su Turati e Buozzi ho già detto. Infine richiamo il discorso che tenne il deputato socialista Giacomo Matteotti alla Camera dei Deputati il 30 maggio 1924, nel quale egli denunciò i brogli che ci furono nelle elezioni che portarono Mussolini alla guida del governo. Come è noto, dopo il suo intervento alla Camera Matteotti venne ucciso dai fascisti. La situazione drammatica che si determinò in quel momento non poteva che avere due possibili esiti: la morte politica di Mussolini, o la sua dittatura…che durò per vent’anni.
Quali errori politici furono allora commessi? Il riformismo socialista (i due termini riformismo/massimalismo chiariscono di per sé i motivi di fondo del contrasto politico), era anche presente allora ai diversi livelli di direzione nel sindacato italiano; forte soprattutto a livello confederale di Cgl, di cui Buozzi infine ne sarebbe divenuto il massimo esponente. Il punto è che quell’insieme di uomini e di idee politiche che definiamo “il riformismo socialista”, si trovò a fronteggiare Mussolini: un uomo politico molto abile, e nei suoi scritti incisivo e trascinatore (traggo questi spunti dall’opinione di Montanelli); e disposto a tutto senza remore morali pur di conquistare il potere politico (oddio, non ricorda Lenin?).
I riformisti per tener testa a Mussolini, avrebbero dovuto costituire al loro vertice un gruppo dirigente coeso, in grado di analizzare gli sviluppi della situazione politica e di intraprendere tutte quelle iniziative necessarie per contrastare il pericolo rappresentato da Mussolini per la democrazia. L’unica strada democratica praticabile era l’accordo con il liberale Giovanni Giolitti; peraltro dallo stesso caldeggiato. Purtroppo non esisteva un tale gruppo dirigente in grado di intraprendere iniziative a nome e per conto dell’eterogeneo schieramento riformista. Per di più, ai riformisti si richiedeva la determinazione necessaria, che non ebbero, di emarginare o se necessario di rompere i rapporti con l’opposizione massimalistica interna al partito, assolutamente contraria all’accordo con Giolitti.
A rendere ancora più contraddittoria la situazione, va anche detto che anni prima di inventare il Fascismo, Mussolini era stato uno dei massimi esponenti del massimalismo socialista. E in seguito alla vittoria dei massimalisti a un congresso del Psi (avvenuta sulla scia della mobilitazione socialista contro la decisione del Governo per la ‘Guerra di Libia’), a Mussolini fu assegnato l’importante incarico di direttore del giornale del partito socialista, l’Avanti! E fu proprio in quel tempo che Mussolini rafforzò notevolmente il massimalismo sindacale con i suoi articoli che spingevano i lavoratori a fregarsene dei sindacalisti riformisti impegnati in difficili trattative per riuscire a dare uno sbocco positivo alle lotte del lavoro molto aspre e spesso esplose spontaneamente;e dunque era Mussolini che incitava i lavoratori a “fare casino permanente” nelle aziende e nella società. In questo Mussolini era coerente con gli orientamenti teorizzati dal ‘casinista’ francese, Sorel; anche se non poteva non rendersi conto, che “fare casino permanente” otteneva un unico risultato: mandare i lavoratori dritti a sbattere la testa contro un muro.
(Se si fosse trattato di un gioco per il miglior protagonista politico, Mussolini l’avrebbe vinto a mani basse con due mosse decisive: prima mettendosi alla testa del ‘casinisti’, e poi di coloro che proclamavano di voler garantire l’ordine contro il caos. Purtroppo non si trattò di un gioco, ma di un dramma che il popolo italiano visse sulla propria pelle, e che divenne tragedia con l’ingresso dell’Italia nell’ultima guerra mondiale).
In conclusione, date le chiare aperture manifestate da Giolitti verso i socialisti, si può senz’altro ipotizzare che se si fosse realizzata l’intesa tra i liberali e i socialisti riformisti, il programma del nuovo governo di coalizione avrebbe compreso la cogestione dei lavoratori nelle aziende (che i socialdemocratici tedeschi otterranno solo negli anni ’70); affermato la non ingerenza del Governo nelle trattative per i rinnovi dei Contratti collettivi di lavoro, che comunque sarebbero stati resi obbligatori per tutti i settori di attività (imponendo così quella obbligatorietà della contrattazione collettiva che il Presidente americano, Delano Roosevelt, – nonostante la forte opposizione della Corte Federale – riuscirà ad affermare soltanto negli anni ’30 durante la Grande Depressione); inoltre per forza di cose (dato il rafforzamento del riformismo sindacale e politico) sarebbero stati migliorati per quanto possibile gli interventi a favore del Welfare State; infine sul tema del divario socio-economico tra nord e sud, di sicuro i socialisti avrebbero richiesto investimenti pubblici in tale direzione, e Giolitti a quel punto non si sarebbe potuto tirare indietro per non compromettere la nascita del nuovo governo da lui voluto. Sta di fatto che un tale accordo non si fece, e ciò va addebitato alla riluttanza dei socialisti riformisti (al di là di adesioni personali a Giolitti che ci furono), di compiere una scelta politica coraggiosa in favore della democrazia, e rompendo definitivamente col massimalismo.
Perciò sono convinto della ragione di quegli storici che sostengono sia stata l’incapacità di decidere dei socialisti riformisti uno dei motivi di fondo (certo non il solo: vedi il ruolo della Monarchia) che causarono la sconfitta della democrazia in Italia. E fu così che mentre in Russia aveva preso il potere il totalitarismo marx-leninista, in Italia prese il potere il nuovo totalitarismo fascista.
Anno 1966. Nenni e Saragat realizzarono l’Unificazione Socialista tra il Psi e il Psdi. Il simbolo elettorale del nuovo partito era bicefalo: comprendeva cioè i due simboli di partito come ruote di una bicicletta contenute in un cerchio. E già questo modo di presentarsi agli elettori lasciava perplessi sulla reale volontà di integrarsi dei due partiti. Eppure c’era stato il tempo necessario per gli approfondimenti, particolarmente stressanti in casa Psi (nessuno mi toglie dalla mente che il Partito socialista in quegli anni fosse assai infiltrato). Per farla breve, alle elezioni il nuovo partito socialista unificato ottenne il 15%; un risultato giudicato al di sotto delle aspettative (la somma dei due partiti presentatisi separatamente alle precedenti elezioni era stata del 20%). Comunque il risultato ottenuto costituiva pur sempre una buona base di partenza (come sostenne anche il repubblicano La Malfa) per riprendere l’iniziativa politica del nuovo partito e andare avanti. Nenni e Saragat avevano ormai esaurito il loro compito, dunque spettava alla nuova classe dirigente unitaria indicare la strada da seguire e le iniziative da intraprendere (naturalmente attraverso un dibattito interno, ma nella comune consapevolezza che le ragioni dello stare insieme erano più forti di ogni altro motivo di divergenza). Tuttavia una tale classe dirigente non esisteva, per il semplice motivo che non si era mai realmente integrata. Infine i due partiti, Psi e Psdi, si separarono di nuovo. Il socialismo italiano subì una seconda sconfitta; e non per un destino cinico e baro, ma per responsabilità dei socialisti stessi. Così il socialismo italiano diviso e in polemica al suo interno non fu in grado di fronteggiare gli avvenimenti che segnarono i terribili anni che videro un arretramento della grande industria italiana, come invece seppero fare i socialdemocratici tedeschi nel difendere la loro economia.
(Ancora peggio dei socialisti si comportarono allora i comunisti; i quali seppure avessero una forza elettorale considerevole e un gruppo dirigente coeso, non vollero seguire le orme della socialdemocrazia tedesca e, con Berlinguer, proclamarono urbi et orbi l’esistenza di una terza via, benedetta dalle parole magiche: il compromesso storico. Tutto ciò mentre le regole del gioco tradizionali del mondo economico entravano in crisi, e via via diveniva più aspro lo scontro commerciale tra i Paesi del mondo, e si creavano le condizioni che avrebbero in seguito consentito le iniziative speculative finanziarie su scala planetaria al di fuori di ogni controllo degli Stati sovrani).
14 – GLI INCONTRI CON CRAXI
Il Psi sotto la guida del segretario De Martino aveva visto ridursi i propri consensi elettorali ai minimi storici. Addirittura De Martino sembrò dare per scontato che il ruolo dei socialisti avesse esaurito il suo compito: un invito neppure troppo velato all’area elettorale orientata verso il socialismo di votare per il Pci; che proprio in quel periodo conseguiva il suo massimo storico elettorale. Ormai noi socialisti della Cgil vedevamo oggettivamente ridursi ai minimi termini i nostri spazi di autonomia e di rappresentanza. Ma a un certo punto fu chiaro che i giochi si sarebbero riaperti a livello politico; e questo avvenne a metà degli anni ’70, quando finalmente si fece avanti nel Psi l’uomo giusto che sarebbe riuscito in breve tempo a occupare il posto giusto: Bettino Craxi.
Ricordo che incontrai a quattr’occhi Craxi due sole volte. Gli chiesi un primo incontro nei primi anni ’80, e me lo concesse nel suo ufficio di Milano. Gli dissi che ero disposto a lasciare il sindacato e a impegnarmi nel partito per dare anch’io una mano: avrei potuto seguire i problemi del lavoro e le politiche sindacali. La mia proposta fu subito accolta. Sulle iniziative che intrapresi a nome e per conto del Psi non mi dilungo; tra le più importanti quella da cui ha preso spunto questa storia (ricordo che fu Ugo Intini, allora direttore dell’Avanti!, a presiedere l’iniziativa di presentazione del mio libro al pubblico e alla stampa).
Il secondo incontro con Craxi avvenne all’Hotel Raphael, quando gli consegnai una copia con dedica del mio libro “Il compromesso dinamico”. Mi ringraziò, ma con la testa era già altrove: solo gli affetti familiari avrebbero potuto lenire la decisione che aveva preso; e dall’esilio tunisino cui poi fu costretto, non rinunciò mai con i suoi scritti a sostenere le buone ragioni del socialismo riformista, democratico, liberale.
Un passo indietro prima dell’ultimo incontro con Craxi all’Hotel Raphael…
15 – IL PATATRAC
Piero Fassino era il tipo di comunista che quando lo sentivo parlare mi veniva da dire: “E’ un socialista mancato”. Lo ascoltai non molto tempo fa rispondere alle domande di un giornalista televisivo sulla violenta contestazione del movimento dei No Tav. Le sue furono parole al tempo stesso chiare, di buon senso e ferme: il progetto di ferrovia Torino-Lione era parte della politica di trasporto per favorire i collegamenti veloci tra i Paesi europei; che gli abitanti della Val di Susa erano stati ascoltati più e più volte (com’era giusto!); che i loro motivi di contestazione erano stati presi in considerazione e per quanto possibile parzialmente recepiti; e dunque non si poteva perdere altro tempo. Non concluse – ma era ovvio –, che lo Stato italiano se non si fosse comportato così, non gli sarebbe rimasto altro da fare che chiudere i battenti; e che di conseguenza nel territorio italiano frantumato secondo la volontà delle comunità locali, sarebbero tornate a governare le Signorie. (Ve lo immaginate Beppe Grillo incontrastato Signore della Val di Susa? Uno spasso irresistibile! Appunto: una comica teatrale. Ma le manifestazioni dei No Tav seguivano purtroppo un altro copione che prevedeva l’uso folle della violenza; un copione arcinoto agli italiani…).
Fassino l’ho incontrato una sola volta; e questo fu proprio alla vigilia del 2° Convegno di Roma che stavo organizzando. Venne a propormi (vado al nocciolo) di organizzare a due, Psi-Pds, il convegno stesso. Gli dissi di indicarmi i nomi degli interventi Pds, che avrei collocato nei momenti giusti durante i lavori del convegno. Quanto alla sua richiesta, non stava a me accoglierla visto che non era stato ancora sciolto in nodo a livello delle segreterie nazionali dei rapporti tra i due partiti. La cosa finì lì.
Intanto la situazione aveva iniziato a precipitare. Craxi lanciò la parola d’ordine dell’”unità socialista” tra Psi e Pds; e alla fine del 1991 appoggiò la richiesta del Pds di entrare a far parte dell’Internazionale Socialista. Al tempo stesso ci fu l’inchiesta di Mani Pulite; a seguire il cosiddetto “circo mediatico giudiziario” che giocò un ruolo di fondo nella delegittimazione e criminalizzazione della politica; quindi il discorso di Craxi nel luglio ’92, che chiese a tutto il Parlamento, governo e opposizione, di assumersi la responsabilità di dare una soluzione politica alla crisi della Prima Repubblica innescata dalla diffusa illegalità dei finanziamenti dei partiti; infine l’ultimo discorso di Craxi a Montecitorio nell’agosto del 1993: “Per quanto riguarda il mio ruolo di segretario politico – dichiarò – io mi sono già assunto tutte le responsabilità politiche e morali che avevo il dovere di assumere, invitando senza successo altri responsabili politici a fare altrettanto con il medesimo linguaggio della verità…”.
Le risposte del Pds alle aperture del leader socialista e ai suoi interventi in Parlamento, furono un silenzio assordante. Era chiaro che il Pds aveva già deciso, e quando venne il momento agì con la stessa logica con cui agisce e si muove un carro armato…
A mio parere, l’errore commesso da Craxi quando lasciò la segreteria del partito, fu di non proporre Claudio Martelli come suo sostituto. Certo, da tutta quella vicenda politica il partito ne sarebbe uscito malconcio: tuttavia rimango convinto che Martelli aveva tutti i numeri per riuscire a far risalire di nuovo la china al Psi.
E fu così che il Partito Socialista Italiano dopo un secolo di vita fu fatto fuori dalla scena politica italiana.
16 – RIFLESSIONI SU QUANTO ACCADUTO PRIMA, DURANTE E DOPO…
Intendo riferirmi unicamente alla logica implicita nei fatti politici che determinarono un tale cataclisma.
Il fatto nuovo straordinario si verificò nel 1989 col crollo del muro di Berlino, cui seguì la fine dell’Urss. Ora in un sito web non si può scrivere un saggio; perciò vado all’essenziale. Certo non si diventa il più forte partito comunista del mondo Occidentale per fortuna o per caso. Al grande successo del Pci hanno concorso molti fattori: i finanziamenti dell’Urss che ha sempre avuto più di un occhio di riguardo nel sostenere i comunisti italiani (Togliatti?); gli errori dei socialisti di cui ho già parlato, che a un certo punto dettero la certezza ai comunisti (accrescendone così la presunzione che incantava i neofiti) di aver vinto la partita a sinistra (che invece verrà riaperta da Craxi); in generale le buone prove (con diverse riserve sulle quali non mi dilungo) che davano di sé i comunisti nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni sociali; l’efficiente organizzazione del Pci che alimentava la fede del cosiddetto ‘zoccolo duro’ dei militanti, stimolandoli a trasmettere ai neofiti la convinzione di essere partecipi di un progetto italiano di ‘respiro storico’ (per intenderci: una via di mezzo tra l’Urss e la Socialdemocrazia europea); un progetto politico – va precisato – che spesso e volentieri diveniva un contenitore di interessi concreti (economici, sociali, di carriera, ecc.) sollecitati dai neofiti e soddisfatti dal Pci. Tutto ciò e altro ancora, può fornire una possibile spiegazione della forte tensione generale che prese il variegato mondo comunista quando crollò l’Urss. Da quel momento Craxi dovette apparire ai loro occhi come il pericolo numero uno, in quanto avrebbe potuto con maggior forza contrattuale mettere in discussione il primato a sinistra del Pci; e dunque rimettere in discussione un’infinità di progetti e di aspettative singole e collettive di gruppi più o meno corporativi.
Fu allora che per i socialisti le cose si complicarono molto. Craxi intervenne alla Camera dei Deputati, e nel suo discorso non si dilungò (fece bene?) a descrivere il quadro storico della guerra fredda mondiale e dei suoi riflessi sulla situazione politica italiana, in cui oggettivamente si iscriveva tra l’altro (e che altro!), anche il capitolo dei finanziamenti illegali o illegittimi ai partiti; che logicamente avevano un nesso con la presenza in Italia del più forte Partito comunista del mondo occidentale. Craxi andò al nocciolo del problema politico come si poneva nella nuova situazione venutasi a creare dopo il crollo del comunismo internazionale. Le sue furono parole di verità e di buonsenso politico. Ciò nonostante, Craxi finì sotto i cingoli…. nell’impeto dell’inchiesta di Tangentopoli (febbraio ’93).
Per completare il quadro dei fatti politici nudi e crudi sopra citati, mi limito a riportare alcune parole sui metodi adottati spesso nelle indagini della Magistratura, espresse dall’allora Presidente della Repubblica, Luigi Scalfaro: “… porre fine alla tortura del tintinnar di manette…”. Per coloro che hanno una coscienza, queste parole dovrebbero indurli a riflettere su quanto accadde allora. Per altri che invece una coscienza non ce l’hanno, a tanti anni di distanza non mi rimane che esprimere il dispiacere umano per la loro condizione…”.
17 – LA FINE DI UN SOGNO POLITICO
In questi anni mi è capitato di chiedermi che cosa sarebbe successo se le indagini allora condotte dalla Magistratura sugli episodi dei finanziamenti illeciti o illegali ai partiti, avessero seguito i metodi e l’impostazione tradizionale del periodo antecedente la caduta del comunismo internazionale.
Il sogno racconta la storia della piena realizzazione del piano B. La segreteria del Pci decide di accogliere le proposte di Craxi; dunque in tempi brevi si individua una soluzione politica al problema della diffusa illegalità dei finanziamenti ai partiti. Chiuso questo capitolo, si apre immediatamente un nuovo capitolo, tenuto conto che il fenomeno dell’uso improprio del denaro pubblico è ormai degenerato al di là di ogni valutazione politica; dunque, un nuovo capitolo che aggravi pesantemente le pene per coloro che mettono le mani sul denaro pubblico per ricavarne un tornaconto personale; e nella consapevolezza che il dna dei cittadini italiani corrotti e corruttori non sia diverso da quello, per esempio, dei francesi o dei tedeschi, un nuovo capitolo che agisca soprattutto sulle norme di prevenzione che riducano drasticamente le opportunità di delinquere in questo campo; e infine i finanziamenti alla politica, che vengano resi assolutamente visibili a tutti i cittadini.
Quindi si apre il confronto ai massimi livelli politici tra i due partiti animati dalla volontà di realizzare l’Unità Socialista su base socialdemocratica. Ai politologi che pensano che quest’idea neppure in un sogno potrebbe essere presa in considerazione, sfugge un dato di fatto fondamentale: la vastità e intensità dei rapporti tra comunisti e socialisti esistenti fin dal dopoguerra nel sindacato, nelle amministrazioni locali in tutta Italia, nelle cooperative, nella miriade di associazioni e organizzazioni con i più vari compiti, funzioni sociali, culturali; parlo di rapporti intensi sul piano politico e umano, che seppure tra gli alti e bassi negli anni non si sono interrotti finché è esistito il Psi; certo rapporti molto ridimensionati dall’indirizzo politico dato da Berlinguer al Pci.
Dunque sarebbe nato un forte Partito socialdemocratico italiano; forte non solo nei numeri, ché i massimi esponenti ex comunisti e socialisti avrebbero concorso al successo del progetto concordando ruoli e responsabilità politiche reciproche prima di integrarsi definitivamente insieme alla base degli iscritti coinvolti fin dalle prime battute.
Un Partito socialdemocratico italiano assai autorevole nell’Unione Europea: una presenza politica dalle idee ben chiare: in un mondo ‘globalizzato’ solo i sistemi-paesi caratterizzati dalla presenza di grandi aziende, o di medie aziende, ma che parlino al mercato mondiale con un’unica voce, sono in grado di giocare un ruolo da protagonista. Dunque un Partito socialdemocratico con un programma socio-economico assai ambizioso, finalizzato alla massima occupazione e all’accrescimento della ricchezza reale e quindi dell’aumento del benessere dei cittadini italiani: comunque non inferiore al livello tedesco.
Come sempre succede nei sogni, sul più bello ti svegli e torni alla realtà. Peccato…
18 – BERLUSCONI
Così dopo i fatti narrati, sono diventato un cittadino italiano senza più il proprio partito politico di riferimento. E quanto alle vicende politiche italiane, le seguivo ma solo quando si discutevano questioni che giudicavo di grande importanza per il futuro del Paese; ché dopo di me, avrebbero seguitato a viverci i miei figli e nipoti.
È innegabile che Berlusconi abbia avuto l’intuizione giusta ad entrare in politica visto l’immediato successo elettorale che ebbe. A volte c’è da sorridere quando si può constatare come nell’analisi politica si arriva a confondere i termini delle questioni. Dunque, per i molti che avevano applaudito freneticamente la fine dell’odiato Craxi, il successo politico di Berlusconi era dovuto solo e soltanto ai suoi soldi e al fatto che fosse proprietario di reti televisive. Mentre per gli estimatori di Berlusconi non c’erano dubbi: dati i risultati rilevanti ottenuti già al suo ingresso in politica, era lui il vero superman! Perciò tutto ciò che diceva e faceva andava considerato come oro colato.
Si comprende meglio il subitaneo successo di Berlusconi, riflettendo sul fenomeno definito Sindrome di Stoccolma: per cui le vittime di un sopruso provano un sentimento positivo nei confronti del proprio sopraffattore. Berlusconi intuì subito, che la stragrande maggioranza degli elettori socialisti che avevano votato Craxi, e quella parte rilevante di elettori Dc i cui esponenti politici nazionali di riferimento avevano fatto un accordo con i socialisti – insomma, gli elettori che ritenevano d’aver subìto un sopruso dopo il radicale cambiamento dello scenario politico -, non fossero stati colpiti dalla Sindrome di Stoccolma; al contrario! Tuttavia essi non avrebbero votato compatti come fecero, se non avessero avuto la chiara percezione che l’uomo che si proponeva di rappresentare la loro protesta silenziosa di vittime politiche, si trovava nelle condizioni di poter esercitare un tale ruolo (e solo per questo motivo, importante ma non decisivo per un grande successo elettorale, funzionarono i mezzi messi a disposizione da Berlusconi). Ora non interessa seguire gli alti e bassi delle successive vicende politiche di Berlusconi, i flussi elettorali che mutano di orientamento nel tempo e sul territorio, gli uomini politici che cambiano casacca e così via. Ciò che si vuole mettere in luce, è che il Berlusconi protagonista della vita politica italiana, nasce da quella prima intuizione che lui ebbe e colse al volo, e che si rivelò azzeccata.
Sorvolo sulla concezione di un Berlusconi superman. Invece intendo cogliere un suo comportamento, dal momento che si presentò vincente sulla scena politica, ruolo che ha mantenuto fino ad oggi. E ciò mi consente di tornare su un argomento cui accennavo all’inizio, e che si concludeva così: ”… ci comportiamo come il Paese degli Allocchi nel mondo globalizzato”.
In ogni Paese produttore di auto, sia a Oriente che a Occidente, la massima autorità di governo nei suoi spostamenti usa un’auto nazionale. Con Berlusconi Presidente del Consiglio, ciò è stato vero per tutti i Paesi del mondo tranne che per l’Italia. Ora se non m’ingannano i ricordi di quando giravo da sindacalista in Europa, e cercavo anche di farmi un’idea della mentalità della gente, ebbene mi sento di poter affermare che un leader politico che avesse vinto le elezioni poniamo in Francia o in Germania – al di là dei suoi gusti personali che avrebbe lasciato in garage -, mai e poi mai avrebbe utilizzano per suoi spostamenti un’auto estera e non nazionale; diversamente, sarebbe entrato subito in rotta di collisione con l’opinione pubblica del proprio Paese. Berlusconi non è uno sciocco; sapeva bene che il suo comportamento nell’usare un auto estera non avrebbe provocato una reazione negativa nell’opinione pubblica italiana; al contrario, essendo allora un vincente sulla cresta dell’onda, sarebbe stato subito imitato per quanto possibile dagli italiani.
(È strano che nessun giornale italiano si sia preso la briga di raccogliere i dati relativi all’andamento delle importazioni di auto della stessa marca usata da Berlusconi dal momento in cui è comparso quotidianamente in Tv; e di altre marche straniere trainate nelle loro esportazioni verso l’Italia dal comportamento di indifferenza mostrato al riguardo da Berlusconi insieme al suo gruppo dirigente).
19 – PATRIOTTISMO: UNA PAROLA FUORI MODA?
Queste considerazioni intendono richiamare l’attenzione sulla punta di un Iceberg i cui 8/10 della parte sommersa contengono i più vari e seri motivi di fondo per cui l’Italia è forse avviata (è destinata?) a diventare una colonia nel mondo globalizzato. Questo discorso chiama in causa una variabile (che si può tenere nel massimo conto, oppure essere completamente ignorata; e tra i due estremi, un’infinità di modi di vedere, di sentire e di comportarsi); variabile che misura una cosa che non ho difficoltà a chiamare col proprio nome: patriottismo.
Beninteso, un tipo di patriottismo operante spontaneamente tra la gente, quale variabile che interviene nelle valutazioni che concorrono alle libere scelte che si compiono, o nelle decisioni della politica su questioni di carattere internazionale: perciò un patriottismo non contraddittorio sia con la volontà di voler stare e rimanere in un mercato aperto, sia con l’obiettivo, ad esempio, della costruzione degli Stati Uniti d’Europa. E dunque un patriottismo che ha a che fare con il concetto di pari dignità.
Il grande obiettivo politico degli Stati Uniti d’Europa (ammesso che vi sia la volontà di volerlo perseguire da parte della maggioranza dei cittadini europei: diversamente, di quale Europa unita parliamo?), certamente imporrà una lunga marcia. Purtroppo si è voluto mettere il carro davanti ai buoi; fuor di metafora: si è voluto far nascere un Parlamento europeo molto costoso e una burocrazia ‘pesante’ ancora più costosa, e questo, prima di aver avviato il lavoro di Commissioni nominate ad hoc dai Governi nazionali e le cui indicazioni, una volta condivise, si sarebbero trasformate in atti amministrativi o leggi nazionali o in interventi politici coordinati o di scambi a livello europeo di medio-alte professionalità impegnate nei medesimi settori pubblici. Il fine sarebbe stato di mettere in moto un reale processo di graduale ‘integrazione europea’ nei settori statuali fondamentali, quali la scuola, la giustizia, l’esercito, il sistema bancario, la politica economico-industriale, la politica estera; e in analogia ai paesi Scandinavi, fin dalle elementari se non prima, si fosse affermato il bilinguismo, per cui la totalità delle nuove generazioni europee avrebbero potuto intendersi ovunque si fossero recate. E poi scrivere in comune una Storia dell’Europa, nel bene e nel male… Dunque una lunga marcia in cui ogni Paese avrebbe contribuito, nella comune consapevolezza che il processo unitario europeo si sarebbe bloccato, se la gente di ogni singolo Paese avesse percepito che l’integrazione che si stava realizzando avveniva a vantaggio di alcuni Stati e a danno del proprio. Quindi una lunga marcia avente l’obiettivo dell’integrazione europea con la necessaria gradualità, ma nella certezza delle tappe intermedie; e fondata sulla pari dignità nelle condizioni socio-economiche dei cittadini europei, ché solo in tal modo il patriottismo di ogni singolo Paese si sarebbe via via diluito nel nuovo patriottismo europeo. E solo a quel punto avrebbe avuto senso eleggere il Parlamento europeo con pieni poteri, e un Governo europeo con gli Stati nazionali equiparati alle attuali Regioni; e con tanti saluti alle Monarchie europee a quel punto divenute incompatibili con gli Stati Uniti d’Europa.
Comunque, cosa fatta capo ha. Ora la domanda è: come mai l’Italia è scesa tanto in basso in Europa?
20 – GLI ERRORI COMUNISTI
A mio parere, la madre dei problemi italiani va individuata nel ritardo ‘storico’ del processo di trasformazione del Pci in partito socialdemocratico o comunque socialista d’impronta europea. Finché è esistita l’Urss, la maggioranza degli ex Pci (colgo il dato politico generale, che è quello che più conta per gli effetti che produrrà sulla situazione politica italiana), ha operato in ogni modo per impedire che si compisse con nettezza una tale scelta (un atteggiamento comprensibile, vivi Stalin e Togliatti, dato il loro fortissimo potere di condizionamento politico interno al movimento comunista: ma dopo la loro morte?). Perfino dopo il crollo del comunismo internazionale, molti di loro sembrarono aver perso il lume della ragione, dando libero sfogo alla propria ‘disperazione politica’ che si manifesterà in ogni modo. Così è successo che dell’area di tradizione socialista, gli stessi riusciranno a farne un deserto; e il cartello ormai rinsecchito che delimitava quell’area ricorda ancora le parole che loro stessi vi avevano scritto: “una componente indispensabile del movimento progressista”.
La crisi della Prima Repubblica ha anche rappresentato una vera e propria manna dal cielo per coloro che dall’estero volevano fare ottimi affari nel nostro Paese; prima in modo soft, e in seguito nei modi spregiudicati e senza più remore. Così senza essere intralciati, si è potuto venire in Italia e far man bassa di acquisti a buon mercato di impianti produttivi e di tecnologie, delle catene della grande distribuzione, alcune banche, alberghi, marchi di abbigliamento e insomma di tutto ciò che avesse un ottimo valore sul mercato internazionale (e spesso si affermava un rapporto tra acquirente colonizzatore e azienda colonizzata insieme ai propri dipendenti).
Una possibile spiegazione di quanto accaduto, può dipendere dal fatto che dopo la Prima Repubblica, l’attenzione politica italiana si sia prevalentemente incentrata sul conflitto-scontro-quotidiano tra gli ex Pci contro il ‘faccendiere’ Berlusconi. E dunque gli ex Pci abbracciavano chiunque incontrassero in Europa, compresi coloro che stavano ridimensionando l’Italia sul piano economico-industriale-politico, per indurli a concentrare la loro attenzione non sulle cause della fine dei socialisti italiani e di Craxi, bensì su Berlusconi: il pericolo numero uno da abbattere nell’interesse dell’Italia, dell’Europa e forse dell’Universo…
21 – MATTEO RENZI E BERLUSCONI
Quanto detto, vale prima che si verificasse l’ingresso sulla scena politica nazionale di Matteo Renzi, che a me pare esprima la politica di quel socialismo liberale di cui ho ampiamente parlato. Confesso di essere rimasto in un primo tempo spiazzato dal comportamento degli elettori in particolare delle ‘regioni rosse’, che hanno consentito a Renzi di ottenere un notevole successo nella corsa per la segreteria del Pd (che è stato propedeutico del successo molto ampio da lui conseguito alle elezioni europee). Che esista davvero uno Stellone d’Italia, che quando meno te lo aspetti faccia rinsavire le persone che avevano perso il lume della ragione? Ma credo che la scelta a favore di Renzi, sia stata determinata da un altro tipo di ‘disperazione politica’ che ha preso il popolo ex comunista, nel momento che ha compreso di avere una propria classe dirigente tradizionale incapace di prospettare un futuro al Paese nelle sfide che lo attendono nel mondo globalizzato.
Beh, staremo a vedere cosa succederà alla seconda puntata: se son rose fioriranno…
Che dire infine di Berlusconi? Voleva fare la rivoluzione liberale, e si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Il motivo? Ha preteso di guidare la notevole forza politica conquistata grazie alla sua giusta intuizione iniziale, con le modalità tipiche della gestione imprenditoriale; ma in tal modo ha ignorato o comunque non ha tenuto in conto la complessità dell’agire politico: nei rapporti con gli amici, con gli avversari politici e con gli elettori. Lo so che vi sono anche altri motivi che hanno messo in difficoltà Berlusconi, e che ricordano le vicende patite da Craxi. Tuttavia ciò non cambia la mia valutazione sull’errore di fondo da lui commesso e che non ha saputo o voluto correggere. E infine per non aver compreso che era venuto il momento di lasciare la guida del partito (il che gli sta facendo commettere ulteriori errori politici), e assumere un ruolo di rappresentanza istituzionale del partito da lui creato (ruolo peraltro assai importante e delicato in una fase di transizione).
Il mio dispiacere per la mancata individuazione di una nuova leadership che unifichi il centro-destra, dovrebbe essere comune a ogni mentalità liberale comunque orientata politicamente; e nasce dalla considerazione politica che ogni democrazia parlamentare per ben funzionare, ha bisogno della concorrenza almeno di due leadership equivalenti quanto alla loro credibilità di essere in grado di assumere la guida del Paese (naturalmente sui programmi e quant’altro, saranno gli elettori a decidere tra i leader in competizione chi guiderà il Paese stesso).
22 – IL MIO MOMENTO DI FOLLIA
Credo che capiti a tutti nel corso della propria vita di fare qualcosa di molto insolito, un po’ folle. A me è capitato quando mi sono reso conto che il libro ‘Il compromesso dinamico’, benché rappresentasse il massimo che ero riuscito a esprimere sul piano intellettuale, poteva anche offrire spunti di riflessione che andassero ‘oltre’ il campo specialistico, sindacale e politico. Ma in che modo ‘andare oltre’?
È del tutto evidente che i contenuti di un saggio così come vengono esposti non hanno nulla a che vedere con un romanzo. Ma potrebbe darsi il contrario: così mi è venuta l’idea di scrivere un romanzo breve, anche per assecondare un mio desiderio a lungo vagheggiato, che riuscisse in qualche modo a veicolare alcune riflessioni stimolate dal mio saggio sulla condizione e natura umana.
Non occorre aver frequentato un corso di scrittura creativa per comprendere che una storia per funzionare deve riuscire a coinvolgere il lettore. E dunque non ci si può limitare a ”dire”, come nel caso dell’esposizione di idee o proposte in un saggio; è necessario che tu riesca a far “vedere” e “sentire” al lettore ciò che pensi (entrando così nel mondo dell’immaginazione, che nello scrivere una storia diviene reale quanto lo è la realtà: Pirandello insegna). E i problemi sono appena agli inizi, se ben ricordo quel tanto di essenziale che ha lasciato in me la montagna di romanzi della Biblioteca Universale Rizzoli che da giovane ho letto; e poi via via i romanzi letti durante la mia vita. Insomma, il punto è che non puoi limitarti a descrivere: bensì devi far sentire, suscitare emozioni… per cui in un romanzo, se ho ben intuito, diviene importante il personaggio che più degli altri interpreta la storia, e che si caratterizza per i problemi che si trascina dietro, e per i suoi conflitti interiori o nei rapporti con altri personaggi; e il tutto all’interno di una trama della vicenda, fino al suo svolgimento conclusivo.
Per non dilungarmi oltre, vado direttamente al lontano ricordo che a un certo momento mi prese, stimolandomi prima a pensare e poi a iniziare a scrivere una storia.
Si tratta di un mio ricordo di studente (di quei ricordi che ti rimangono per sempre impressi nella memoria): un breve incontro sul bus cittadino con la mia prof d’italiano della Scuola tecnica industriale ‘Duca D’Aosta’ di Roma. Non mi accorsi subito della sua presenza, anche se il bus non era strapieno; solo avevo ancora nelle orecchie la strapazzata del nostro allenatore. Infatti alcuni giorni prima nel torneo Allievi di basket (allora era d’obbligo adottare il termine italiano, Pallacanestro), la squadra della nostra Scuola cui facevo parte, aveva affrontato la squadra avversaria ‘Stella Azzurra’ di un Liceo diretto dai gesuiti vicino Piazza di Spagna. E noi figli di operai eravamo andata a giocare nel cortile cinquecentesco del Liceo, attrezzato da campo di basket, sicurissimi di non far toccar palla a quei figli di papà. Accadde invece il contrario: perdemmo in modo vergognoso la partita… Intanto la prof d’Italiano aveva fatto alcuni passi verso di me, e mi chiese cosa portassi nel borsone a tracolla. Dissi qualcosa sull’allenamento di quel giorno, sulla partita persa e degli urlacci dell’allenatore. Mi guardò e sorrise benevola in modo più aperto di come faceva sempre quando mi riconsegnava il mio tema d’italiano con un buon voto. Trascorsero alcuni momenti di silenzio, mentre lei guardava oltre i finestrino del bus come a inseguire un suo precedente pensiero; e poi mormorò come parlando a se stessa: ognuno porta la sua croce (a scuola si sapeva che il marito, ufficiale dell’esercito, era tornato dal fronte con le gambe amputate). Il bus aprì le porte, lei si diresse per scendere, e si voltò ancora verso di me: scriva Mezzanotte, scriva…
Ma scrivere cosa?, visto che la scuola che frequentavo ci preparava sì molto bene, ma per diventare degli operai specializzati. Così la lettura divenne la mia valvola di sfogo: leggevo di tutto, e ho seguitato a farlo. Ancora oggi ogni volta che passo davanti una libreria, è più forte di me: non posso fare a meno di fermarmi. Ma cosa è rimasto nella mia memoria di tante letture? A essere sinceri, non lo so.
Chissà, forse con l’età che avanza (cerco di mantenere in esercizio il fisico andando in palestra due volte alla settimana), sono stato preso dal mio momento di follia, e iniziato a scrivere una storia o romanzo breve; la cui trama dopo un lungo vagabondare della mente, infine si era chiarita al punto che mi erano diventati perfino familiari i personaggi che vi comparivano; quando…
Quando mio figlio alcuni mesi fa mi telefonò per informarmi che il mio saggio ‘Il compromesso dinamico’ era riportato in molti siti web: bastava che su Google digitassi il titolo del libro seguito dal mio nome. Lo feci, e con mia meraviglia scoprii che il mio saggio a tanti anni dalla sua pubblicazione ancora viveva di vita propri+ Da quel momento usai il computer non solo come una efficientissima macchina per scrivere, ma anche per girovagare su internet. Confesso che mi fece un certo effetto (non sono un uomo di spettacolo) riascoltare la mia voce su radio radicale, che aveva registrato pensate un po’ un convegno del Psi di cui ero stato relatore circa trent’anni fa. E poi le numerose citazione di diversi miei articoli e interventi da segretario della Federbraccianti.
Pensai ai quattro gatti che per puro caso avevano incrociato il mio nome navigando su internet. Mi venne il desiderio di informarli (loro che sicuramente se ne fregavano) che ero ancora vivo e vegeto; e visto che ogni volta che veniva citato il mio libro, si invitava chi lo desiderasse a esprimere la propria opinione, decisi come ho già spiegato di tornare sull’argomento. Rimaneva da informare i personaggi del romanzo sulla novità sopraggiunta. Mi venne in soccorso una novella di Pirandello: misi un cartello nell’anticamera del mio cervello, in cui pregavo i personaggi di non disturbarmi durante il tempo in cui ero impegnato a scrivere i testi per questo sito web; e che presto con mio grande piacere si saremmo rincontrati, e finalmente avremmo ripreso insieme a raccontare la nostra storia.
23 – LE MIE IDEE POLITICHE
La mia partecipazione ai convegni degli ‘Amici del Mondo’, cui seguì l’iscrizione al Psi (ne ho già parlato), mi piace ricordare che fu determinata dalla scoperta in quei miei anni giovanili del libro che sarebbe diventato in un certo senso la mia bibbia-laica: “Storia della filosofia occidentale, e dei suoi rapporti con le vicende politiche e sociali dall’antichità ad oggi”, di Bertrand Russel. (“Il compromesso dinamico” riprende molto in alcune sue parti dal libro di Russell; che dopo diversi anni ho dovuto far rilegare, per poter seguitare a consultarlo senza distruggerlo).
La mia posizione politica giovanile di sinistra era maturata nell’ambito familiare (mio padre era autista dell’azienda di trasporto pubblico del Comune di Roma), e poi confrontandomi con i miei compagni di lavoro; infine sono approdato – dopo aver riflettuto e stimolato dal libro di Bertrand Russel -, su una posizione politica di socialismo liberale che rifiuta risolutamente ogni concezione dogmatica e ideologica, e segue la Stella Polare di quegli ideali definiti come meglio non si potrebbe da Bettino Craxi: “Gli ideali e non le ideologie sono i veri motori del progresso umano. L’uomo ha sempre bisogno di maggiori spazi di libertà, di guadagnare maggiore benessere, di vivere in una comunità migliore, cioè più giusta e più equilibrata. Riformare e rinnovare è un’attività continua diretta allo sviluppo dell’individuo e della società in tutte le sue esigenze materiali, culturali e spirituali…”
Riguardo le mie scelte operative, mi sono sempre ispirato al sano pragmatismo di stile americano: Prendere ciò che funziona, scartare tutto ciò che non funziona.
Dunque spero di aver chiarito qual è stata la radice ideale e politico-sindacale e da quali mie esperienze di vita sia scaturito “Il Compromesso Dinamico”: libro che allego in questo sito web, per dar modo, a chi lo desideri, di leggerlo.
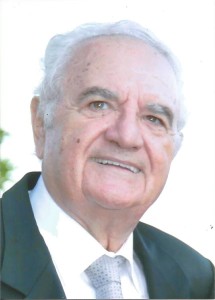 Sono Mario Mezzanotte, l’autore del libro “Il compromesso dinamico – Una risposta a Ralf Dahrendorf”, presentazione di Luciano Pellicani, edito da Ponte alle Grazie, Firenze, 1992.
Sono Mario Mezzanotte, l’autore del libro “Il compromesso dinamico – Una risposta a Ralf Dahrendorf”, presentazione di Luciano Pellicani, edito da Ponte alle Grazie, Firenze, 1992.